Tra i disegni di
scenografia più suggestivi per un architetto ci sono senz’altro quelli di Adolphe
Appia. Mostrano spazi di grande serenità, costituiti da pochi elementi
semplici: pilastri squadrati e disposti in sequenza, scale in pietra che risalgono
per piani senza diventare mai troppo ripide. Suggeriscono l’idea di un
movimento pacato, rituale, e guidano lo sguardo oltre l’inquadratura, in uno
spazio che non è dato vedere ma che l’immaginazione, a partire dallo scorcio
che gli è concesso osservare, continua a figurarsi per intero, con le stesse
armonie pacate, segnato da una materia altrettanto solida, da una luce
altrettanto precisa. Una luce che è quasi densa, atmosferica, il più delle
volte crepuscolare, e traccia ombre nettissime e allungate, mai cupe, tenui,
quasi trasparenti. Guardando quei disegni, senza conoscerne la storia e l’origine,
si penserebbe a vedute di architetture arcaiche, rovine esistenti e conosciute,
non ai bozzetti per una scena teatrale.
Appia è stato per
il teatro una personalità decisiva: il ruolo che gli affidano le storie è
quello del grande rinnovatore, di chi ha cambiato l’idea della messa in scena
dopo secoli di tradizione attoriale. E lo ha fatto a partire dai suoi disegni e
dalle pagine dei suoi scritti, da un punto di osservazione eccentrico rispetto
alla realtà e alla pratica dei teatri, degli allestimenti concreti che riuscì a
realizzare poche volte e molto tardi nella sua vita. A volte, parlando di Appia,
gli storici costruiscono un parallelo tra teatro e pittura e parlano degli
impressionisti: non lo fanno per lo stile dei suoi bozzetti, ma per la rottura
che i suoi lavori segnano per il teatro, paragonabile alla rivoluzione compiuta
da Monet e dai suoi compagni. C’è anche chi si riferisce a Cezanne, a Van Gogh:
e neppure questo è un accostamento per via di forme o di stile, è invece un’affinità
spirituale più alta, più profonda, quella che lega chi è destinato a svolgere un ruolo
decisivo ma vive ai margini della cultura che dovrà condizionare; di chi soffre per tale
condizione e vive la propria arte insieme con un malessere radicato dal quale
non riesce a separarla.
Le vedute
architettoniche di Appia, così affascinanti per noi, hanno avuto un’influenza profondissima
nel teatro del Novecento, da Gordon Craig a Svoboda. Sono state la prima
palpabile testimonianza di un’idea di teatro come opera d’arte e non più, soltanto,
come mestiere, come semplice imitazione naturalistica, più o meno riuscito trompe l’oeil. Nei disegni di Appia l’evocazione
non nasce dall’affollamento di dettagli particolari, ma da una rinuncia, dalla
determinazione a non voler ripetere meccanicamente ciò a cui si tende, a cui si
rimanda. Una rinuncia, una riduzione: quanto meglio si riesce a contenere, a
rendere concisi i segni, l’insieme degli oggetti sulla scena, tanto più
potente sarà l’evocazione, tanto maggiore sarà la forza intrinseca della
composizione, l’autonomia e la coerenza dell’opera, del teatro come atto poetico pieno ed autonomo.
I testi di
Appia, nella loro traduzione italiana (curata da Ferruccio Marotti), sono disponibili
in rete. Questo è il link per scaricarli in pdf:
Una bella introduzione racconta la vita dell’autore e descrive i temi
principali dei suoi scritti.



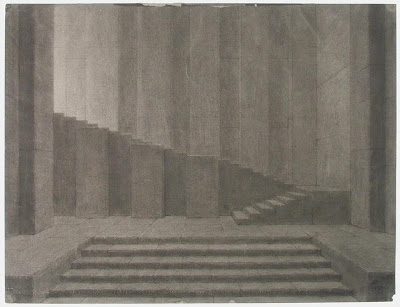
Nessun commento:
Posta un commento